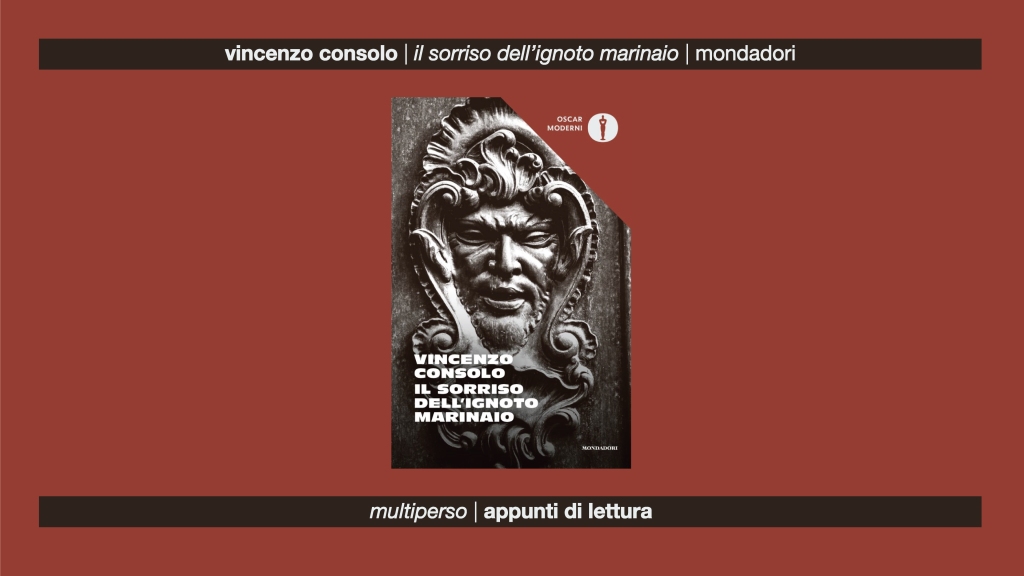In agosto le giornate, dopo essersi allungate a dismisura, sfilacciate in un tiro alla fune senza fretta, fatto di pennichelle, aperitivi, cene, musica e frescura che tarda ad arrivare, improvvisamente si accorciano. Il sole tramonta in anticipo, lo vedi inarcarsi più in fretta, come se non vedesse l’ora di nascondersi dietro l’orizzonte. Il tempo diminuisce e così la luce. Una luce piena che si dimezza, poi si annulla e si scopre un buio oltre il buio, di cieli senza stelle e riflessi invisibili. La più totale oscurità. Il precipitare della luce si ritrova in 22 racconti che sembrano un calendario estivo, un promemoria giornaliero, un viaggiare progressivo verso la notte: il buio mangia ogni cosa e con sé trattiene l’eccitazione estiva e la consapevolezza, più o meno risentita, di un tempo che è destinato a finire. Ho sentito la luce spegnersi. Smarrimento da fine della festa, speranza da primo bicchiere, delusioni all’alba, paure e bagni di mezzanotte. Finché persino nel buio non si possano iniziare a distinguere i confini, i profili, facce di cose che volevamo fare, che possiamo ancora fare. Ogni testo ha un odore. Qualcosa che entrando nel naso finisce per solleticare collegamenti inaspettati, accende visioni e costruisce ponti lunghi centinaia di ricordi: così appare l’immagine, netta e definita, un nome che torna senza bisogno di presentarsi. L’odore, in queste pagine, è quello della franchezza. Una sorta di leggero disincanto e amore per la verità, in senso più ampio. Vite che si vivono nel loro tempo, senza aspettarsi nessun miracolo né bramare alcuna vendetta. Del tipo: ecco a voi il mondo, vorrei raccontarvi dell’altro, ma questo è. Ed è per me fondamentale nella scrittura, mi sembra indispensabile, una chiave che apre e realizza le storie. E nella lettura diventa un ago, sottile al limite dell’invisibile, che si insinua sotto la pelle e fa male, malissimo. Sgorga un’unica goccia di sangue, rosso e limpido, pronta a confondersi nel mare e in quelle onde estive che, con masochistica abnegazione, continuano ad andare e venire, andare e venire, andare e venire. Poco importa che in cielo cambi la luce o che addirittura scompaia.
Francesco Spiedo